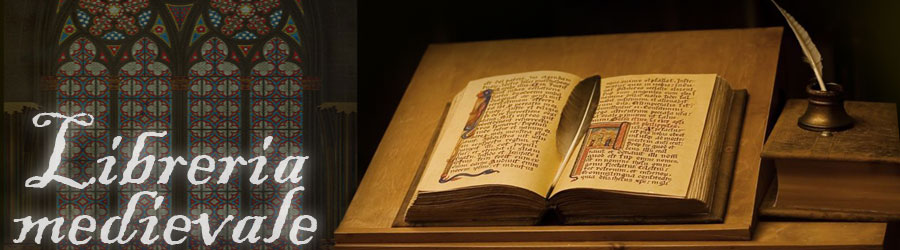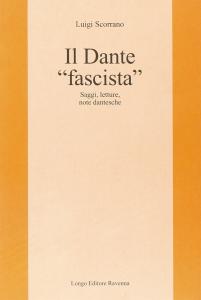Il Dante "fascista". Saggi, letture, note dantesche
CODICE: ISBN 8880632906 EAN 9788880632900
AUTORE/CURATORE/ARTISTA :
Autore: Luigi Scorrano
EDITORE/PRODUTTORE : Angelo Longo Editore
COLLANA/SERIE : L'interprete, 68
DISPONIBILITA': Disponibile
TITOLO/DENOMINAZIONE:
Il Dante "fascista". Saggi, letture, note dantesche
PREZZO : EUR 18,00€
CODICE :
ISBN 8880632906
EAN 9788880632900
AUTORE/CURATORE/ARTISTA :
Autore: Luigi Scorrano
EDITORE/PRODUTTORE:
Angelo Longo Editore
COLLANA/SERIE:
L'interprete, 68
ANNO:
2001
DISPONIBILITA':
Disponibile
CARATTERISTICHE TECNICHE:
212 pagine
Brossura
cm 14 x 21 x 1,5
gr 328
DESCRIZIONE:
Quarta di copertina:
Dante è, nelle pagine del libro di Scorrano, al centro di un'indagine variamente articolata ma unitaria. Si va dalla "Lectura" in senso istituzionale, ma con novità di prospettive (Inf. XIII, Purg. III e XXVI) all'esplorazione della "presenza-fortuna" di Dante dal Cinquecento al Novecento. In Cellini, Sereni, Moravia, Piovene, Bevilacqua sono saggiati modi e forme del "riuso" del dettato dantesco, ma anche le ragioni profonde che lo definiscono e lo giustificano. Non un semplice rilevamento di somiglianze o identità verbali, ma ricerca di affinità ed esplorazione del dialogo intrecciato attraverso il tempo col grande modello.
Il saggio sul Dante "fascista" costituisce un singolare ed intrigante capitolo della "fortuna" dantesca. Un curioso scenario che vede il poeta arruolato forzatamente come precursore o compagno di strada nell'impegno della militanza politica durante il ventennio mussoliano.
indice:
pag. 7 Premessa
9 I. Inferno XIII: un orizzonte di negazione
29 II. Dall'abbandono alla bontà riconquistata (Purgatorio III)
51 III. "per aquella valor". Il canto XXVI del Purgatorio
69 IV. "Gli ha letto Dante". Occasioni dantesche nella Vita del Cellini
89 V. Il Dante "fascista"
127 VI. Dantismo 'trasversale' di Sereni
169 VII. Luca Mansi quasi Bonconte
181 VIII. Dante, Piovene e Le stelle fredde
197 IX. Microdramma "dantesco" in un romanzo di Alberlo Bevilacqua
202 Nota
203 Indice dei nomi
GENERE: Libri ,Saggi ,