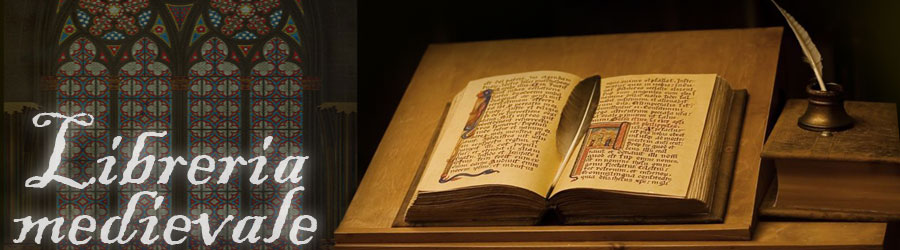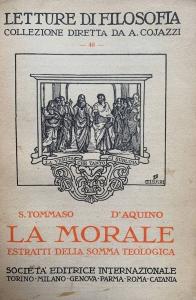La morale. Estratti della Somma teologica
BUONE CONDIZIONI
CODICE:
AUTORE/CURATORE/ARTISTA :
Autore: San Tommaso d'Aquino Traduzione, introduzione e note a cura di: Ulisse Pucci
EDITORE/PRODUTTORE : SEI Società Editrice Internazionale
COLLANA/SERIE : Letture di filosofia, 40
DISPONIBILITA': In esaurimento
TITOLO/DENOMINAZIONE:
La morale. Estratti della Somma teologica
BUONE CONDIZIONI
PREZZO : EUR 24,50€
CODICE :
AUTORE/CURATORE/ARTISTA :
Autore: San Tommaso d'Aquino Traduzione, introduzione e note a cura di: Ulisse Pucci
EDITORE/PRODUTTORE:
SEI Società Editrice Internazionale
COLLANA/SERIE:
Letture di filosofia, 40
ANNO:
1934
DISPONIBILITA':
In esaurimento
CARATTERISTICHE TECNICHE:
228 pagine
Brossura
cm 13 x 20 x 1,4
gr 211
NOTE:
VOLUME IN BUONE CONDIZIONI
DESCRIZIONE:
Indice:
Introduzione:
pag. 5 I. - Il problema morale nella filosofia antica
5 1. La Morale nella filosofia prearistotelica
7 2. La Morale di Aristotele
16 3. La Morale post-aristotelica
17 II. - La Morale di S. Tommaso
41 Prologo
Questione I. Del fine supremo dell'uomo
43 Articolo I. All'uomo conviene di agire per un fine
44 Art. II. L'agire per un fine è proprio della natura ragionevole
46 Art. III. Gli atti umani ricevono la loro specie dal fine
46 Art. IV. La vita umana ha un fine supremo
48 Art. VI. L'uomo tutto quello che vuole lo vuole per il fine ultimo
48 Art. VII. L'ultimo fine di tutti gli uomini è uno solo
Questione II. Alle ricerca del bene sommo
51 Articolo I. La felicità dell'uomo non consiste nelle ricchezze
52 Art. II. Neppure gli onori possono costituire la felicità umana
53 Art. III. La felicità umana non può esser data dalla fama e dalla gloria
54 Art. IV. La felicità dell'uomo non consiste nella potenza
55 Art. V. La felicità dell'uomo non consiste nei beni del corpo
56 Art. VI. La felicità dell'uomo non può consistere nel piacere
57 Art. VII. La felicità dell'uomo non consiste neppure in un bene dell'anima
59 Art. VIII. La felicità dell'uomo non consiste in nessun bene creato
Questione III. La felicità o beatitudine
61 Articolo I. In qual senso la felicità dell'uomo è qualcosa di increato
63 Art. II. La felicità dell'uomo consiste in un'attività
64 Art. IV. La felicità consiste, essenzialmente, in un atto dell'intelletto; accidentalmente, in un atto della volontà
65 Art. V. La felicità è, in modo primario, un'operazione dell'intelletto speculativo; in modo secondario, dell'intelletto pratico
67 Art. VI. La felicità non può consistere nella considerazione delle scienze speculative
69 Art. VII. La felicità non consiste nella conoscenza delle sostanze separate e, cioè, degli Angeli
69 Art. VIII. La felicità dell'uomo consiste nella visione dell'essenza divina
Questione V. Il conseguimento della felicità
71 Articolo I. L'uomo può conseguire la felicità
72 Art. VII. Perchè l'uomo possa conseguire la felicità sono necessarie opere buone
Questione VI. Del volontario e dell'involontario
76 Articolo I. Gli atti umani sono volontari
78 Art. II. Gli animali senza ragione non agiscono, propriamente parlando, volontariamente
79 Art. III. In qual senso il volontario può esistere senza alcun atto
80 Art. IV. La volontà non può essere violentata
81 Art. V. La violenza può essere causa di atti involontari
81 Art. VI. In qual senso il timore rende assolutamente involontari gli atti che ispira
83 Art. VII. Gli atti compiuti per concupiscenza sono volontari
84 Art. VIII. In qual senso siano involontari gli atti compiuti per ignoranza
Questione VIII. L'atto di volontà
87 Articolo I. La volontà non può volere che il bene
Questione IX. Dei motori della volontà
89 Articolo I. L'intelletto muove la volontà
91 Art. II. Come la volontà può esser mossa dall'appetito sensibile
92 Art. IV. La volontà per muovere se stessa ha bisogno anche di una causa esterna
93 Art. V. In qual senso la volontà subisca l'influsso del Cielo
94 Art. VI. Solo Dio può muovere la volontà come causa esterna
Questioni X-XVII. L'atto della volontà
I modi dell'attività volontaria
97 (X, I) La volontà tende naturalmente verso il bene
98 (X, II) La volontà è mossa necessariamente dal suo oggetto?
99 (X, III) Può l'appetito sensibile muovere necessariamente la volontà?
100 (X, IV) Dio, considerato come motore esterno della volontà, non la muove necessariamente
Del godimento
101 (XI, I) Il godere è un atto della potenza appetitiva
101 (XI, II) Il godere è, in senso stretto, solo dell'uomo
102 (XI, IV) Il godimento implica il possesso del fine
Dell'intenzione
103 (XII, I) L'intenzione è un atto della volontà
103 (XII, II) L'intenzione non si rivolge solo al fine ultimo
104 (XII, III) L'intenzione può simultaneamente rivolgersi verso più cose
104 (XII, IV) L'intenzione del fine può identificarsi con la volontà dei mezzi
105 (XII, V) L'intenzione, propriamente parlando, non conviene agli animali
Dell'atto della volontà che si riferisce ai mezzi, ossia, della scelta
106 (XIII, I) La scelta è un atto della volontà
107 (XIII, II) La scelta non conviene agli animali
107 (XIII, VI) La scelta dell'uomo è libera
Del consiglio che precede la scelta
108 (XIV, I) Il consiglio è un esame
Del consenso
110 (XV, I) Il consenso è un atto dell'appetito
111 (XV, II) Propriamente parlando il consenso non conviene agli animali
111 (XV, III) Il consenso riguarda i mezzi, non il fine
Dell'uso volontario dei mezzi
112 (XVI, I) L'uso è un atto della volontà
Degli atti imperati dalla volontà
113 (XVII, I) L'impero è un atto della ragione che presuppone un atto della volontà
114 (XVII, II) L'impero non conviene agli animali
115 (XVII, V) L'atto della volontà può essere imperato
115 (XVII, VI) Anche l'atto della ragione può essere imperato
116 (XVII, VII) Gli atti dell'appetito sensibile non sono sempre imperati
117 (XVII, VIII) La ragione non ha l'impero degli atti della vita fisiologica
Questione XVIII. Della bontà e della malizia degli atti umani in generale
119 Articolo I. Gli atti umani possono essere buoni o cattivi
121 Art. II. La bontà e la malizia dell'atto umano derivano dall'oggetto
122 Art. III. La bontà e malizia di un atto derivano anche dalle circostanze
123 Art. IV. Un atto umano è buono o cattivo in ragione del fine
124 Art. V. Gli atti buoni o cattivi differiscono secondo la specie
125 Art. VI. Gli atti umani ricevono una specie di bontà e di malizia anche dal fine
126 Art. VIII. Un atto umano, considerato nella sua specie, può essere moralmente indifferente
127 Art. IX. Nessun atto umano, considerato concretamente, può essere indifferente
128 Art. X. Una circostanza può dare ad un atto morale una nuova specie di bontà e di malizia
Questione XIX. Della bontà e malizia dell'atto interno della volontà
131 Articolo I. La bontà del volere dipende dall'oggetto
132 Art. III. La bontà del volere dipende dalla ragione
133 Art. IV. La bontà del volere dipende dalla Ragione eterna
134 Art. V. Il volere che non s'accorda colla ragione, vera o falsa, è malvagio
136 Art. VI. Non sempre la ragione erronea rende buono l'atto della volontà
137 Art. VIII. Il grado di bontà del volere non corrisponde sempre a quello dell'intenzione, il grado di malizia sì
139 Art. IX. La bontà del volere dipende dalla sua conformità alla volontà divina
Questione XX. Della bontà e malizia degli atti umani esterni
141 Articolo I. La bontà o malizia consiste più nell'atto interno o in quello esterno?
142 Art. II. Bontà e malizia dell'atto esterno
143 Art. IV. L'atto esterno può accrescere la bontà o malizia dell'atto interno
144 Art. V. Come le conseguenze di un atto esterno possono aumentarne la bontà o la malizia
Questione XXI. Le conseguenze degli atti umani
147 Articolo I. Un atto umano, in quanto è buono o cattivo, implica la nozione di rettitudine o di peccato
148 Art. II. Un atto umano, in quanto è buono o cattivo, è degno di lode o di biasimo
149 Art. III. L'atto umano, in quanto è buono o cattivo, implica merito o demerito
150 Art. IV. L'atto umano ha un valore di merito o di demerito anche davanti a Dio
Questioni XXII-XXIV. Le passioni
Del soggetto delle passioni dell'anima
153 (XXII, I) Come le passioni si trovino nell'anima
154 (XXII, III) La passione è più propriamente nell'appetito sensibile che nella volontà
Differenza delle passioni
155 (XXIII, I) Vi è differenza tra le passioni della potenza concupiscibile e di quella irascibile
156 (XXIII, IV) Classificazione delle passioni dell'anima
Del bene e del male nelle passioni umane
157 (XXIV, I) Le passioni possono essere buone o cattive
158 (XXIV, II) Le passioni dell'anima non sono, moralmente, tutte cattive
159 (XXIV, III) Le passioni possono accrescere o diminuire la bontà o malvagità dell'atto
Questioni LV-LXVI. I principi interiori degli atti umani
L'essenza della virtù
163 (LV, I) La virtù umana è un abito
164 (LV, II) La virtù umana è un abito operativo
165 (LV, IV) La virtù è definita giustamente come "una qualità o un abito della mente secondo la quale si vive bene, della quale nessuno si serve male e che Dio opera in noi senza di noi"
167 (LVIII, III) Le virtù sono sufficientemente distinte in morali e intellettuali
168 (LVII, II) Le virtù intellettuali speculative sono tre: sapienza, scienza, intelletto
169 (LIX, V) Non si danno virtù morali senza passione
171 (LXI, II) Le virtù cardinali sono quattro
172 (LXII, I) Necessità delle virtù teologali
173 (LXII, III) Le virtù teologali sono propriamente tre
174 (LXIII, III) Esistono anche virtù infuse
La via della virtù
175 (LXIV, I) La virtù consiste nel giusto mezzo
176 (LXIV, II) La determinazione del giusto mezzo
Il rapporto tra le virtù
177 (LXV, I) Le virtù cardinali sono connesse tra loro
180 (LXV, II) Se le virtù morali possono esistere senza la carità
181 (LXV, III) La carità non esiste senza le altre virtù morali
181 (LXVI, III) Le virtù intellettuali sono più nobili di quelle morali
182 (LXVI, IV) La giustizia è la pìù grande delle virtù morali
183 (LXVI, V) La sapienza è la più grande delle virtù intellettuali
185 (LXVI, VI) La carità è la più grande delle virtù teologali
Questioni LXXI-LXXVII. Dei vizi e dei peccati
187 (LXXI, I) Il vizio è contrario alla virtù
188 (LXXI, VI) Il peccato è convenientemente definito: "un detto, un fatto, o un desiderio contro la legge eterna"
189 (LXXII, IV) I peccati sono convenientemente distinti in peccati contro Dio, contro se stesso e contro il prossimo
190 (LXXIII, III) La gravità dei peccati varia secondo gli oggetti
192 (LXXIV, II) Soggetto del peccato non è la sola volontà
192 (LXXVI, II) L'ignoranza può costituire peccato
194 (LXXVI, IV) L'ignoranza può diminuire la gravità del peccato
195 (LXXVII, II) Come la ragione possa essere vinta dalla passione nonostante la propria scienza
197 (LXXVII, VII) La passione può scusare dal peccato anche totalmente
198 (LXXVIII, III) Vi sono peccati di malizia che non sono prodotti da un abito
Questioni XC-XCVII. I principi esterni degli atti umani
Le leggi
201 (XC, I) La legge è un principio di ordine razionale
202 (XC, III) Il fare leggi non appartiene a tutti
203 (XCI, I) Esiste una legge eterna
203 (XCIII, III) Ogni altra legge deriva dalla legge eterna
204 (XCI, II) Esiste nell'uomo una legge naturale
Il contenuto della legge naturale
206 (XCIV, II) Tutti i precetti della legge naturale si possono ridurre ad uno: fare il bene, evitare il male
208 (XCIV, III) Non tutti gli atti virtuosi appartengono alla legge di natura
209 (XCIV, IV) La legge di natura è la stessa per tutti?
210 (XCV, I) Sono necessarie anche leggi umane
211 (XCVI, II) La legge umana non può proibire tutti i vizi
212 (XCVI, IV) Le leggi umane giuste obbligano la coscienza dell'individuo
214 (XCVI, VI) Come deve essere interpretata la lettera della legge
215 (XCVII, I) Le leggi umane sono variabili
216 (XCVII, II) Le leggi umane non si devono mutare. se non per gravi ragioni
GENERE: Fonti ,Libri ,