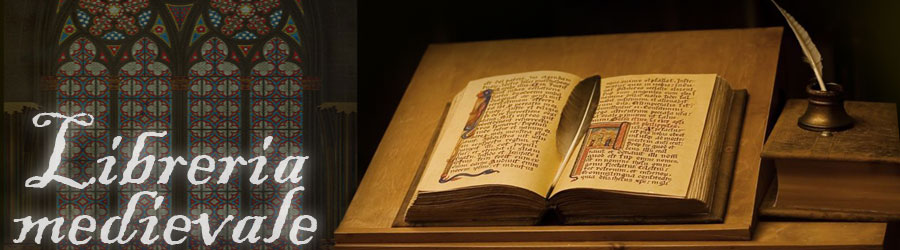L'idea deforme. Interpretazioni esoteriche di Dante
BUONE CONDIZIONI
CODICE: ISBN 8845214427 EAN 9788845214424
AUTORE/CURATORE/ARTISTA :
Autore: Maria Pia Pozzato, Hekena Lozano, Maria Lacalle, Sandra Cavicchioli, Cinzia Bianchi, Claudia Miranda, Regina Psaki A cura di: Maria Pia Pozzato Introduzione di: Umberto Eco Postfazione di: Alberto Asor Rosa
EDITORE/PRODUTTORE : Bompiani
COLLANA/SERIE : Il campo semiotico
DISPONIBILITA': In esaurimento
TITOLO/DENOMINAZIONE:
L'idea deforme. Interpretazioni esoteriche di Dante
BUONE CONDIZIONI
PREZZO : EUR 54,50€
CODICE :
ISBN 8845214427
EAN 9788845214424
AUTORE/CURATORE/ARTISTA :
Autore: Maria Pia Pozzato, Hekena Lozano, Maria Lacalle, Sandra Cavicchioli, Cinzia Bianchi, Claudia Miranda, Regina Psaki A cura di: Maria Pia Pozzato Introduzione di: Umberto Eco Postfazione di: Alberto Asor Rosa
EDITORE/PRODUTTORE:
Bompiani
COLLANA/SERIE:
Il campo semiotico
ANNO:
1989
DISPONIBILITA':
In esaurimento
CARATTERISTICHE TECNICHE:
330 pagine
Brossura
cm 13,5 x 21,5 x 2,8
gr 412
NOTE:
VOLUME IN BUONE CONDIZIONI
DESCRIZIONE:
Quarta di copertina:
Fin dal secolo scorso sono state proposte letture occultistiche, esoteriche, ermetiche di Dante (spesso in chiave rosicruciana e massonica). Secondo tali interpretazioni, svillaneggiate dalla critica ufficiale (De Sanctis e altri), Dante non avrebbe scritto quello che sembra avere scritto, in quanto ogni sua parola non sareb-be altro che un messaggio in codice che allude all'esistenza della setta ereticale dei Fedeli d'Amore.
La ricerca, introdotta da un saggio di Umberto Eco e con una postfazione di Alberto Asor Rosa, affronta autori "classici" sul Dante "ermetico" (Gabriele Rossetti, Eugène Aroux, Giovanni Pascoli, Luigi Valli, Rodolfo Benini, René Guénon) ponendosi varie domande: quale metodo seguivano questi autori? a quali ragioni è dovuta la ripulsa totale che hanno subito? quali delle loro intuizioni sono poi state accettate dalla critica successiva, anche se per altre vie? che cosa c'era di "sbagliato" nelle loro ipotesi?
Indice:
pag. 9 Umberto Eco, INTRODUZIONE - LA SEMIOSI ERMETICA E IL "PARADIGMA DEL VELAME"
16 L'analogia universale, il segreto e il complotto
19 L'interpretazione sospettosa
23 I limiti dell'interpretazione
27 Lo slittamento del senso
34 Il paradigma del velame
34 Conclusione in guisa di prefazione
39 Maria Pia Pozzato, PREFAZIONE
47 1. Helena Lozano Miralles, "DANTIS AMOR": GABRIELE ROSSETTI E IL "PARADIGMA DEL VELAME"
51 1.1. La genesi del "paradigma del velame"
52 1.2. La sapienza pervicace
56 1.3. Nella selva indiziaria
61 1.4. Il segreto è il linguaggio
66 1.5. L'innocenza dello studioso. Le ragioni del fallimento
75 1.6. La funzione oracolare
79 Maria R. Lacalle Zalduendo, IL DANTE ERETICO, RIVOLUZIONARIO E SOCIALISTA DI EUGÈNE AROUX
82 2.1. La genealogia del Dante "eretico"
88 2.2. I contratti fiduciari: il lettore modello
91 2.3. Il contratto con la Chiesa
95 2.4. Il contratto con la scienza
97 2.5. L'esegesi
101 2.6. Il duello con la critica
107 3. Sandra Cavicchioli, GIOVANNI PASCOLI: DEL SEGRETO STRUTTURALE NELLA "DIVINA COMMEDIA"
109 3.1. Il tipo di interpretazione
111 3.2. Il dramma del riconoscimento
114 3.3. Le condizioni della ricerca ovvero l'istituzione del segreto
115 3.3.1. La costruzione dell'anomalia
118 3.3.2. Duplicità del segreto
120 3.4. La costruzione del soggetto dell'interpretazione
121 3.4.1. Dante come alter ego
121 3.4.2. La conoscenza come contatto diretto
124 3.5. Effetti discorsivi del segreto come efficacia
126 3.5.1. Ossessione parafrastica e pulsione affabulatoria
127 3.5.2 Propedeutica dell'enunciatario
129 3.5.3 L'isotopia patemica
130 3.6. Strategie interpretative: l'eccesso di struttura
131 3.6.1. Corrispondenze per antitesi e chiasmi
133 3.6.2. Referenti interni e omologazioni
136 3.6.3. Scorrettezza e produttività
138 3.6.4. "Coniuncta membra" intertestuali
139 3.7. I limiti dell'interpretazione
147 4. Maria Pia Pozzato, LUIGI VALLI E LA SETTA DEI "FEDELI D'AMORE"
148 4.1. L'ipotesi della setta
148 4.1.1. Le variazioni intensive dei parametri di giudizio
151 4.1.2. I Fedeli d'amore e la Santa Sapienza
153 4.2. La polemizzazione della ricerca: amici e nemici
153 4.2.1. I predecessori e il "paradigma del velame"
155 4.2.2. I successori e le prospettive della ricerca
156 4.3. Il contesto di interpretazione: "farsi l'occhio", "farsi l'orecchio"
156 4.3.1. Costruzione e sanzione dell'"oggetto teorico"
158 4.3.2. La coerenza del discorso
160 4.3.3. L'intertesto come "supercontesto aspecifico"
161 4.3.4. L'interpretazione globale
162 4.3.5. Le opinioni orientative
163 4.3.6. Il puzzle settario
165 4.3.7. Il tonfo degli esempi
166 4.4. I livelli di interpretazione: un gergo che non è un gergo
166 4.4.1. Il codice gergale
167 4.4.2. La riduzione dei livelli interpretativi
168 4.4.3. La reificazione dell'assiologia
170 4.4.4. Codice gergale o sceneggiature?
173 4.4.5. La "penombra connotativa" dei tratti passionali
175 4.4.6. Il carattere strumentale delle poesie settarie e la regolazione pragmatica del significato
177 4.5. Le diverse ragioni per credere
177 4.5.1. La visione etico-fiduciaria della scienza
178 4.5.2. Rivelazione ed efficacia dell'interpretazione
179 4.5.3. L'addestramento del neofita
181 4.5.4. La strategia di esemplificazione
182 4.6. Un senso, due verità, nessuna verifica
182 4.6.1. Invenzione e scoperta. La costruzione del discorso "vero"
184 4.6.2. Le condizioni di verificabilità della teoria
186 4.6.3. Consapevolezza epistemologica e commisurazione fra paradigmi
191 5. Cinzia Bianchi, RODOLFO BENINI: UN'INTERPRETAZIONE IN CHIAVE NUMEROLOGICA DELLA "DIVINA COMMEDIA"
192 5.1. La "genialità" di Dante
192 5.1.1. La struttura dell'opera
195 5.1.2. Il segreto da scoprire
196 5.2. Il mondo esterno e l'enigma
197 5.2.1. Il segreto "referenziale"
199 5.2.2. Il segreto "enigmatico"
202 5.3. Il costo della coerenza
202 5.3.1. La coerenza d'insieme
203 5.3.2. Controfatti e rompicapi
214 5.4. Il riconoscimento della teoria
214 5.4.1. I "logici" e la "critica ufficiale"
216 5.4.2. Il gruppo di riferimento
219 5.5. La richiesta della fiducia
219 5.5.1. Il simulacro d'attività
221 5.5.2. Gli elementi di persuasione
224 5.6. Gli "eccessi" dell'interpretazione
227 6. Claudia Miranda, RENÉ GUÉNON O LA VERTIGINE DELLA VIRTUALITÀ
229 6.1. Un paradigma esoterico
230 6.1.1. Il quarto senso, un senso iniziatico
232 6.1.2. I presupposti del paradigma
238 6.2. L'intertesto esoterico: tradizione e tradimento
242 6.3. Parlar tacendo o tacer parlando: la semiosi sfrenata
248 6.4. Insegnare nascondendo
253 6.5. Un discorso invulnerabile
256 6.6. Il circolo ermetico
263 7. Regina Psaki, LA CRITICA DANTESCA ORTODOSSA E GLI ALLEGORISTI
265 7.1. La critica positivista
269 7.2. La critica estetico-idealista
273 7.3. Gli allegoristi e gli studi danteschi contemporanei
281 8. Maria Pia Pozzato, CONCLUSIONI
295 Alberto Asor Rosa, POSTFAZIONE
317 BIBLIOGRAFIA, a cura di Regina Psaki
GENERE: Libri ,Saggi ,