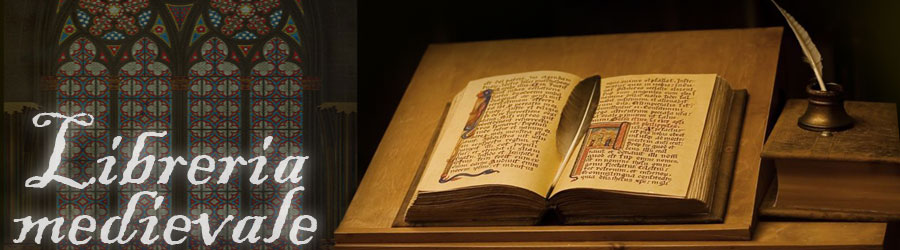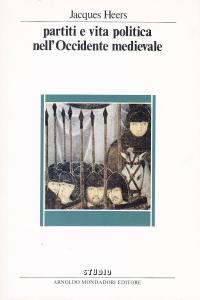Partiti e vita politica nell'Occidente medievale
CODICE:
AUTORE/CURATORE/ARTISTA :
Autore: Jacques Heers Traduzione di: Tukery Capra, Giampaolo Garavaglia
EDITORE/PRODUTTORE : Arnoldo Mondadori Editore
COLLANA/SERIE : Studio
DISPONIBILITA': In esaurimento
TITOLO/DENOMINAZIONE:
Partiti e vita politica nell'Occidente medievale
PREZZO : EUR 14,00€
CODICE :
AUTORE/CURATORE/ARTISTA :
Autore: Jacques Heers Traduzione di: Tukery Capra, Giampaolo Garavaglia
EDITORE/PRODUTTORE:
Arnoldo Mondadori Editore
COLLANA/SERIE:
Studio
ANNO:
1983
DISPONIBILITA':
In esaurimento
CARATTERISTICHE TECNICHE:
286 pagine
Brossura
cm 13,5 x 20 x 2
gr 350
DESCRIZIONE:
Quarta di copertina:
Nella sua ricostruzione delle lotte sociali e di fazione in Italia e in Europa tra il 1100 e il 1400 e del primo abbozzarsi di ciò che più tardi si configurerà come la struttura dei «partiti» politici, Heers si propone di dissolvere i luoghi comuni che orientano le tradizionali interpretazioni di questa fase della storia medievale: l'idea che la lotta politica in quest'epoca possa essere vista come lotta di classe o come conflitto tra aggregati sociali definibili secondo criteri economici; che la storia italiana si possa riassumere in una storia di «città» e del predominio di aristocrazie urbane «borghesi» o mercantili; o che il conflitto tra Guelfi e Ghibellini (denominazioni che nascondono realtà politiche, economiche e sociali profondamente diverse da luogo a luogo) sia schematicamente riducibile all'adesione rispettivamente alla Chiesa e all'Impero. Questi pregiudizi della storiografia sul Medioevo vengono quindi sostituiti da un'analisi che, procedendo con criteri di tipo storico-antropologico, restituisce al loro ruolo fondamentale i legami di natura verticale tra clan familiari, casate, «gentes», con i loro seguiti, le loro «clientele» e «masnade»; viene ricostruita la realistica, violenta fisionomia dei conflitti e delle guerre e l'assenza di motivazioni ideologiche che li sottende, cui si ricollegano la pratica dell'eliminazione totale della parte sconfìtta, con la distruzione di case, la confisca di beni e l'esilio, l'importanza della vendetta e la costante conflittualità che oppone tra di loro vincitori ed esuli.
Particolare importanza riveste infine l'analisi delle nazioni di «parte» e di «popolo», volta a sottrarre questi concetti a connotazioni ideologiche posteriori e a ricostruire il loro significato originario di aggregazioni non socioeconomiche, ma politico-territoriali.
Sommario:
pag. 7 Introduzione
Parte prima
Le fazioni politiche nell'Italia medievale. 1100-1400
21 I. L'Italia medievale: un terreno di studi privilegiato
21 Le strutture sociopolitiche nelle città italiane
26 Pressioni esterne
28 Il problema delle fonti
32 II. La nozione di partito nel vocabolario delle città medievali italiane
33 L'incerta evoluzione del termine «partito»
38 Incertezze nella scelta dei nomi dei partiti
45 III. Le rivalità politiche
46 Rivalità esterne
58 Rivalità interne. I partiti e il potere nelle città
70 IV. Rivalità e pressioni economiche
70 I contrasti economici e le loro armi
72 Ricchi contro poveri?
74 Nobili e popolani
82 V. I legami di vicinato
82 La città era divisa in due blocchi contrapposti?
86 Luoghi di riunione e centri di raccolta
89 Ruolo politico dei quartieri
92 Conclusioni
Parte seconda
Reclutamento e struttura dei partiti
95 I. Famiglie e clientele
95 Faide e vendette
101 Le famiglie nei partiti
106 Partiti e clientele
110 II. Città e campagna
111 I legami città-campagna e i partiti
119 I partiti nelle campagne
126 III. Il governo dei partiti
127 Podestà e capitani
130 Il partito e il governo della città
134 Il partito trascende il Comune
Parte terza
L'Italia: le forme della guerra e della pace
145 I. La città in armi: la guerra civile
146 Combattimenti e sommosse
156 La mentalità collettiva, crudeltà e massacri
163 II. La sorte dei vinti
163 Condanne ed esecuzioni. Rappresaglie contro i beni
169 Perdite e confische
171 L'esilio
182 III. La pace e il popolo
182 La pace e i movimenti di pace
190 Iniziative politiche e ordinamenti diretti a mantenere la pace
Parte quarta
I partiti politici fuori d'Italia
205 I. I partiti nel quadro urbano
205 La prima età comunale
210 Il periodo delle grandi metropoli mercantili
223 Altre città occidentali?
227 II. I partiti dei nobili. Montagne e Paesi di confine
Parte quinta
Mentalità collettiva e società politiche
233 I. La competizione, sostegno morale del gruppo politico
233 Le testimonianze letterarie
237 Il sentimento religioso: il caso dei «Patarini» a Milano
240 Il sentimento religioso: prediche, processioni, scomuniche
244 II. Lo spirito di competizione. Le feste e i giochi di guerra
244 Le feste e l'esaltazione del potere politico
247 Il trionfo del partito vincente
249 La festa, occasione di disordini
253 Feste e competizioni: i giochi di guerra
256 III. Lo spirito di competizione. Le insegne e le adunate
256 Richiami di guerra
257 Insegne e vessilli
260 I partiti e i colori
267 Bibliografia
271 Indice analitico
GENERE: Libri ,Saggi ,